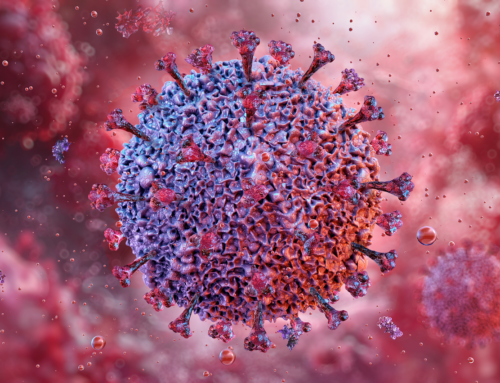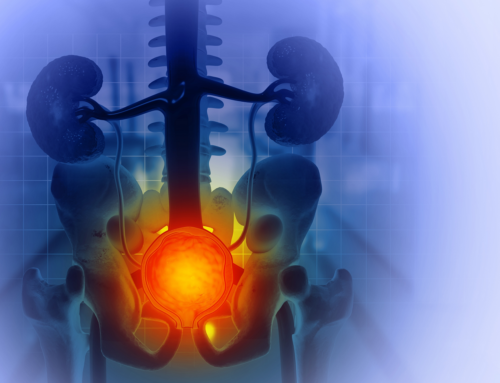Dalle molecole alla società: quant’è complesso il dolore
Articolo del 29 Ottobre 2021
Il Nobel per la Medicina e la Fisiologia del 2021 ha premiato due scoperte nel mondo della percezione umana. Una di queste racconta la biologia della risposta al calore e rivela una porta di ingresso per una delle nostre più utili e profonde sensazioni. In quest’articolo, una panoramica di quanto sappiamo dei meccanismi del dolore, fisico e psicoemotivo, e delle sfide ancora aperte in medicina, soprattutto per quanto riguarda il dolore cronico.
1997, David Julius scopre un recettore molecolare di membrana in grado di percepire temperature al di sopra dei 43 gradi. Non temperature qualunque ma le portatrici di un segnale preciso: un potenziale danno dei tessuti, un probabile dolore. TRPV1 – questo il nome del recettore – traduce un’informazione termica esterna in un segnale elettrico interno. Avverte una caratteristica dell’ambiente e la traduce in un linguaggio che il sistema nervoso è in grado di comprendere. Come? TRPV1 è un canale ionico di membrana, una proteina che funziona da portale per l’ingresso di cationi bivalenti (ioni con due cariche positive, per esempio calcio e magnesio) all’interno della cellula nervosa. Come un termometro molecolare, se la temperatura supera i 43 gradi, se scotta, TRPV1 modifica la propria conformazione e si apre, innescando una corrente depolarizzante che attiva una particolare classe di neuroni che informano il sistema nervoso centrale di quel calore pericoloso. Nel 1997 Julius ha scoperto uno dei meccanismi molecolari che usiamo per percepire il mondo intorno a noi e 23 anni dopo, in seguito a ulteriori indagini e caratterizzazioni di TRPV1 e alla scoperta di una controparte per il freddo (TRPV8), riceve il Nobel per la medicina e la fisiologia, condiviso con il collega Patapoutian, che ha scoperto un simile traduttore molecolare per il tatto.
La scoperta di Julius però, è stata l’inizio anche di un’altra storia.
La scintilla che accende il dolore
Ciò che TRPV1 percepisce è un mondo pericolosamente caldo che ci provoca dolore. I segnali dannosi vengono trasmessi al cervello tramite componenti nervose particolari che costituiscono il sistema della nocicezione. Nella cute e nei tessuti profondi, dimorano infatti terminazioni nervose libere, chiamate nocicettori, che captano variazioni termiche, chimiche o meccaniche nocive, e le trasmettono lungo le proprie fibre alle corna dorsali del midollo spinale (la zona del midollo deputata alla ricezione di informazioni sensoriali dal corpo).
A chi non è capitato di prendere la pentola dell’acqua bollente senza presine? In quel caso TRPV1 si apre, lancia l’invio di un segnale urgente, inequivocabile segno di pericolo. Ecco che alla nostra coscienza affiora un dolore acuto che ci porta a mettere in atto un comportamento di rimozione o evitamento della fonte di danno. Ma la cosa non finisce qui. Una volta lasciata la pentola, i segnali nocicettivi riprendono a viaggiare, sebbene più lentamente, usando fibre amieliniche, creando quella sensazione di dolore persistente che ci dice che oramai un po’ di danno è fatto e che dovremo proteggere quella zona fin quando non sarà guarita. Se ci siamo bruciati, inoltre, per un po’ di tempo quell’area diventerà ipersensibile ad altri eventuali stimoli termici, proprio grazie a TRPV1. Le cellule danneggiate infatti rilasciano varie sostanze chimiche che aumentano la sensibilità del recettore. In particolare, il pH acido, caratteristico dell’infiammazione, abbassa la soglia di apertura del canale determinando una risposta eccessiva della proteina, causando il fenomeno della sensibilizzazione periferica.
La nocicezione dunque aiuta a proteggerci. Ma in questo caso la nostra coscienza non riceve una semplice informazione, come quando tocchiamo qualcosa, ma un’esperienza più complessa che nella storia ha alimentato letteratura, filosofia e scienza: il dolore. Limitandoci a quest’ultimo, di cosa si tratta?
Gli ingredienti del dolore
Quando l’informazione viaggia dalla terminazione libera del neurone nocicettore verso il midollo spinale, i neuroni del corno dorsale accolgono il segnale e lo rimandano a varie aree cerebrali, tra cui il talamo, una struttura sottocorticale che ha il ruolo di filtrare le informazioni e smistarle verso le preposte aree corticali. Quando la corteccia finalmente riceve il segnale, lo legge e lo interpreta, lo integra e lo elabora, e, in qualche centinaio di millisecondi, ecco che appare. Il dolore viene definito come un’esperienza sensitiva, privata e soggettiva, associata a una condizione di danno reale o potenziale di un tessuto. Esperienza soggettiva, perché non dipende interamente dallo stimolo esterno, non dipende solo dal canale TRPV1. Nocicezione e dolore sono fenomeni collegati ma distinti, perché la prima è una diretta manifestazione sensitiva mentre il secondo è il risultato di una “lavorazione” più complessa.
Il dolore è infatti il prodotto di una personale elaborazione inconscia di vari segnali, che vengono integrati dal cervello secondo un principio dominante di significato. È il significato che quel segnale porta, e il contesto che trova, a determinare la nostra percezione di dolore. La creazione della sensazione dolorosa avviene attraverso l’attivazione e la comunicazione reciproca di numerose aree cerebrali, poiché numerosi sono i fattori (biologici, psicologici e sociali) che interagendo ne influenzano la genesi.
Il dolore fisico presenta una componente sensitiva, codificata dalle cortecce sensoriali (S1 e S2) che identificano la localizzazione e l’intensità dello stimolo. Queste caratteristiche si integrano poi con una componente affettivo-emotiva che permette di elaborare una risposta comportamentale adeguata. La corteccia cingolata anteriore (ACC), parte del sistema limbico, e la corteccia insulare (IA), tra le numerose funzioni che svolgono, sono le principali responsabili della sensazione di spiacevolezza del dolore. Queste si attivano vigorosamente quando veniamo sottoposti a stimoli dolorosi e una loro lesione può provocare la scomparsa della risposta emozionale o del comportamento di evitamento in presenza di stimoli nocivi. Le due aree, a differenza della corteccia sensoriale, si attivano anche in presenza di un dolore non fisico, supportando l’idea che il dolore psicoemotivo o sociale condivida parte dei circuiti nervosi con la sua controparte corporea. Probabilmente è dal dialogo tra queste due zone, e le loro rispettive strutture di afferenza e proiezione (tra cui l’amigdala), che scaturisce il ben noto “mi fa male” di una ferita, fisica o interiore. Un ultimo ingrediente va aggiunto: contemporaneamente, o forse anche in via prioritaria, la corteccia prefrontale valuta lo stimolo presentato dalla nocicezione, alla ricerca del suo significato. Ed è qui che il dolore prende o perde la sua forza. È qui che diventa una “questione privata”.
Il mio dolore, per la mia sopravvivenza
Il dolore ci difende da una minaccia fisica, psicologica o sociale che può mettere a repentaglio financo la nostra stessa sopravvivenza. Così come una ferita ci rende più deboli, anche un evento di esclusione sociale può comportare un rischio per la nostra incolumità, poiché indica una perdita della protezione del gruppo, su cui noi esseri umani facciamo grande affidamento. La corteccia prefrontale dunque guarda allo stimolo nocivo con questo intento, valutando il significato del segnale per capire quanto la minaccia sia pericolosa. Per fare ciò effettua delle stime, fa previsioni e attinge alle esperienze passate, valutando lo stimolo in base alla propria visione del mondo. Quanto più allarmante è il risultato, tanto più intensa sarà la percezione di dolore che affiora alla nostra coscienza. La principale componente soggettiva del dolore quindi è nella visione che abbiamo del suo significato. E questo processo di valutazione, a parità di stimolo, può essere diverso per ciascuno. Per esempio, è stato dimostrato che una visione “catastrofica” del dolore, concepito come schiacciante e insuperabile, è correlata a un aumento dell’intensità percepita, che invece diminuisce se ci sentiamo di avere il controllo della situazione.
Il contesto diventa quindi un altro elemento fondamentale, che plasma e influenza la nostra percezione. Un contesto inteso come situazione di pericolo estremo per la sopravvivenza, per esempio, induce l’adrenalina e gli oppioidi endogeni a silenziare il dolore perché altrimenti occuperebbe tutta la nostra attenzione, impedendoci di agire per salvarci. Un particolare contesto sociale, dove i valori e le tradizioni diventano indicatori di significato, ci induce a sopportare dolori se abbiamo una motivazione culturale per farlo. Infine, un contesto corporeo caratterizzato da una condizione di stress può alterare gli equilibri ormonali, ridurre le capacità di controllo della corteccia prefrontale, compromettendone la funzionalità, e agire su altre zone del cervello per mantenerci in uno stato costante di ipervigilanza, tutte condizioni che aumentano l’intensità del dolore percepito.
Da sintomo a malattia
C’è un dolore tuttavia che non gioca completamente secondo le regole. Il dolore acuto, funzionale e significativo, che indica un danno da gestire e una zona del corpo da proteggere, in alcuni casi può cronicizzare. Il dolore diventa cronico quando va oltre la sua funzione evolutiva: non più un sintomo ma una malattia, anzi un grappolo di condizioni patologiche che ne aumentano la complessità di comprensione e trattamento. Quando una lesione è incurabile, il dolore cronico si definisce nocicettivo e indica una condizione persistente di infiammazione e disagio dei tessuti, come in casi di osteoartrosi o malattie oncologiche. Quando poi è la fibra nocicettiva stessa ad aver subito una lesione, il dolore cronico si definisce neuropatico, mentre se è la manifestazione di un malfunzionamento nel sistema di rilevamento di danno, gli studiosi parlano di nocipatia. Infine esiste una forma di dolore cronico che non è associata ad alcuna motivazione organica, ovvero l’origine non è nota, come cefalea o molte forme di mal di schiena. In alcuni casi, quest’ultimo probabilmente deriva da un maladattamento: l’avere paura di un dato dolore, poiché indicatore di un danno in realtà inesistente. Per esempio, se il cervello impara ad associare il dolore alla schiena a un danno dei tessuti o dei muscoli, la paura di lesionare il nostro corpo può portarci in un costante stato di allerta, che ci rende ipervigili verso ogni segnale di dolore.
Curare la complessità
Le diverse cause dunque, non completamente note, del dolore cronico lo rendono una sfida attuale per la medicina e un problema per il sistema sanitario. Lo dimostra per esempio l’epidemia di disagio sociale e correlato dolore cronico nella classe media bianca negli Stati Uniti, che ha dato origine alle cosiddette “morti per disperazione”, da suicidio, alcol e abuso di oppiodi, analizzate dal premio Nobel 2015 per l’economia Angus Deaton e dalla collega e moglie Anne Case. Il proliferare del dolore cronico tocca anche il nostro Paese. Circa un quarto della popolazione italiana soffre infatti di questa condizione che influenza fortemente la qualità della vita e che ha portato, nel 2010, all’approvazione della legge 38 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a coloro che ne hanno bisogno.
La questione non è di facile risoluzione. Vista la molteplice natura del dolore cronico, le attuali terapie non sempre funzionano in maniera universale o definitiva. Il trattamento del dolore necessita di un approccio multimodale, che sedi l’infiammazione se presente, che silenzi i sistemi di nocicezione se malfunzionanti e che stimoli il cervello a depotenziare il dolore, sia tramite il sistema antidolorifico naturale (mediato da neurotrasmettitori come dopamina e noradrenalina, e da oppioidi endogeni) sia tramite l’estinzione di un apprendimento maladattativo (paura appresa del dolore).
Una questione privata
La sfida principale è tuttavia come gestire la natura privata del dolore. Ad oggi, infatti, non esiste un sistema di valutazione oggettiva dell’intensità della sensazione dolorifica, lasciandola vincolata alla comunicazione verbale. Non esiste un parametro di riferimento comune a tutti. Negli ultimi anni sono stati individuati metodi alternativi, soprattutto mirati ai soggetti che non sono in grado di parlare, come pazienti in età neonatale o in coma. L’analisi dell’elettroencefalogramma nei neonati ha portato all’identificazione di una serie di parametri caratteristici della percezione del dolore. Mentre tramite risonanza magnetica funzionale è possibile individuare una “firma” di attivazione cerebrale correlata alla sensazione dolorifica. Nonostante questi risultati, per ora il metodo più affidabile e comunemente usato si basa su una scala numerica grazie a cui il paziente riferisce l’intensità percepita.
Il dolore quindi, acuto o cronico, fisico o psicosociale, si complica ulteriormente nella sua dimensione privata, irriducibilmente opaca all’altro. Eppure, visto il suo ruolo fondamentale per la sopravvivenza, rimane anche un’esperienza condivisa probabilmente con tutto il mondo animale. E bene ha fatto l’Accademia di Stoccolma a ricordarne la rilevanza con il Nobel alla medicina di quest’anno.