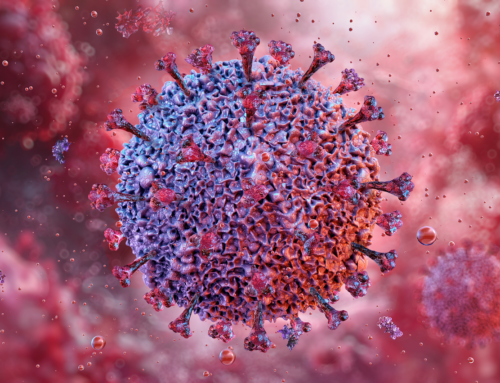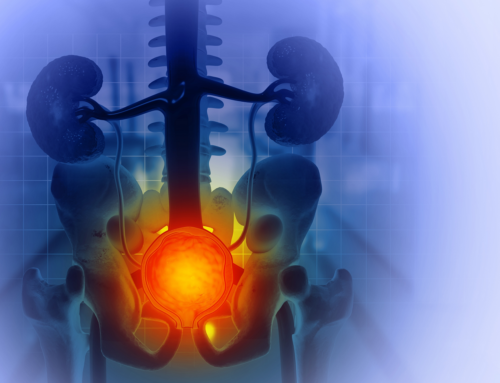Perché la denatalità è un problema per il welfare
Articolo del 23 Marzo 2022
La denatalità è un problema che interessa l’Italia da anni e, con la pandemia, le cose sono peggiorate. Il tasso di fecondità (cioè il numero medio di figli per donna) nel 2019 era pari a 1,29, tra i più bassi in Europa e ben sotto la soglia che garantirebbe il ricambio generazionale (circa 2,1 figli). Nel 2021, il calo dei nati è stato tra i più ampi mai registrati, come spiega il secondo rapporto del Gruppo di esperti “Demografia e Covid-19” di recente pubblicazione.
Questo inverno demografico ha un forte impatto sulla sostenibilità dello Stato sociale. Una popolazione sempre più anziana, infatti, fa lievitare i costi del sistema previdenziale e del Sistema Sanitario Nazionale. Se però la popolazione attiva diminuisce, il numero di contribuenti cala e la fiscalità generale si addossa un peso che non può sopportare.
Perché succede
I motivi per cui una persona sceglie o meno di avere figli sono influenzati da molti fattori, alcuni individuali, altri che riguardano la società nel suo complesso. Ad esempio, la stabilità economica di un individuo – l’avere un’occupazione sicura, un reddito adeguato e un’abitazione – influisce sulla scelta di diventare genitore. Molti studi, tra cui quelli di D’Addio e Mira D’Ercole (2005, 2006), affermano che anche la situazione economica di un Paese, le politiche per la famiglia e l’offerta di servizi pubblici possono influire sull’opportunità di avere figli.
Da non sottovalutare sono poi l’incertezza e la sfiducia verso il futuro, che possono derivare dalla situazione politica e sociale (crisi economiche, guerre), ma anche da catastrofi naturali (come le epidemie). Tutti questi fattori interagiscono tra loro e possono a loro volta influenzarne altri. Ad esempio, la letteratura suggerisce che le donne più istruite siano meno propense ad avere figli, a meno che non riescano a beneficiare di adeguate politiche di conciliazione (Joshi 1990; D’Addio e Mira d’Ercole 2005, 2006).
Cosa fa l’Europa
Se il calo della natalità è un problema che riguarda soprattutto i Paesi dell’Europa meridionale, è però vero che il tasso di fecondità medio europeo è comunque pari a 1,5 (sempre inferiore alla soglia di ricambio generazionale). Ma che cosa ha intenzione di fare l’Unione Europea per risolvere il problema?
Bisogna premettere che l’evoluzione demografica è un ambito che riguarda le politiche sociali, un settore che rientra tra le competenze concorrenti dell’Unione Europea. Ciò significa che i Paesi dell’UE legiferano e adottano atti vincolanti quando l’Unione decide di non farlo. Chiarito questo aspetto, l’invecchiamento demografico è una delle 6 priorità della Commissione per il quinquennio 2019-2024 (la priorità “A new push for European democracy”).
La Commissione ha poi una vicepresidente che si occupa di democrazia e demografia, la croata Dubravka Šuica. Il tema, fino ad ora, è stato affrontato in due modi. Da un lato, nel gennaio 2021, a seguito di una consultazione pubblica, è stato pubblicato un Libro verde sull’invecchiamento demografico, per promuovere lo sviluppo di un welfare che accompagni le persone per tutto il corso della loro vita. Dall’altro, nel marzo dello scorso anno, sono state adottate una strategia generale sui diritti dei minori e una garanzia per l’infanzia.
L’importanza delle politiche per la famiglia
Investire molto in politiche per la famiglia è una condizione fondamentale per poter contrastare la denatalità. Queste politiche agiscono utilizzando tre strumenti principali:
- fornitura di servizi di cura per i bambini;
- trasferimenti monetari legati alla presenza di figli;
- strumenti per la gestione del tempo, come congedi parentali od obblighi contrattuali relativi alla flessibilità lavorativa.
Queste misure si legano strettamente anche alle politiche di conciliazione, perché di fatto aiutano le famiglie a gestire le responsabilità lavorative e la cura dei figli, questione particolarmente importante soprattutto per le donne. Infatti, anche se sempre di meno e sempre in meno Paesi, sono ancora le donne a sopportare il maggior carico di lavoro non retribuito (di gestione della casa e di cura dei propri cari). Inoltre, delle politiche di conciliazione efficaci garantiscono anche una sicurezza economica alle donne, che non sono costrette ad abbandonare il lavoro per occuparsi della propria famiglia. E, come dicevamo, questo è proprio uno dei fattori che influenzano il tasso di natalità.
Un modello che riesce a sintetizzare bene tutto questo è quello di Antonietta Confalonieri (2017). La studiosa, basandosi sugli studi di Esping-Andersen (1990) e Ferrera (1996) sui diversi sistemi di welfare, ha elaborato una matrice in cui inseriscono due dimensioni: la prima è la spesa dei Paesi dell’Europa occidentale per le politiche per la famiglia (in termini tecnici policy effort); la seconda sono gli esiti di genere nel mercato del lavoro, misurabili dai tassi di occupazione femminile. Grazie a queste due dimensioni, è possibile distinguere quattro modelli di politiche per la famiglia, tenendo conto che comunque la classificazione è una semplificazione e ci sono variazioni importanti tra Paesi.
I modelli che generano esiti simmetrici nel mercato del lavoro (cioè un tasso di occupazione femminile molto vicino a quello maschile) sono quello scandinavo – tipico di Paesi come la Svezia – e quello liberale, di cui un caso emblematico è il Regno Unito. Il modello continentale – il cui esempio principale è la Germania – e quello sud-europeo – di cui fa parte ad esempio l’Italia – danno invece origine a esiti asimmetrici (con un alto gap tra tassi di occupazione femminili e maschili).
Rispetto al policy effort, i modelli si dividono tra alta spesa per le politiche (scandinavo e continentale) e basso grado di sostegno (liberale e sud-europeo). Da notare che questa classificazione è riferita ai Paesi europei di metà anni 2000: soprattutto nei modelli asimmetrici, molti Paesi nel tempo sono intervenuti con diverse riforme, generando esiti diversi rispetto a quelli dell’inizio degli anni 2000.
Ma come funzionano questi modelli?
In Svezia l’assegno universalistico per ciascun figlio esiste dal 1948, mentre i congedi parentali per entrambi i genitori risalgono al 1974. Attualmente ci si può astenere dal lavoro fino a 480 giorni, di cui i primi 390 sono retribuiti fino all’80%. Per incentivare i padri a usare i propri giorni di paternità, nel 1995 sono stati introdotti dei congedi per i primi mesi dei figli non trasferibili alle madri: se un papà decide di non usarli, perde definitivamente la possibilità di usufruirne. Per quanto riguarda i servizi di cura per i bambini sotto i tre anni, una riforma degli anni 2000 ha riconosciuto il diritto di accesso agli asili, anche nel caso in cui i genitori stiano ancora studiando o siano disoccupati.
In Regno Unito, i genitori ottengono un assegno per i figli se il loro reddito annuo non supera le 60.000 sterline. C’è poi un assegno una tantum di 500£ per i primi figli. Il congedo di maternità è di 52 settimane, ma solo le prime 39 sono retribuite. Il congedo di paternità può essere invece di una o due settimane a scelta ed è retribuito a quota fissa. Vi è poi la possibilità di ottenere un congedo condiviso dai genitori. A livello di servizi per la prima infanzia, il Regno Unito prevede l’accesso gratuito agli asili solo sotto una certa soglia di reddito per i bambini di due anni.
Passiamo al caso tedesco. Fino agli anni ’90, in Germania le politiche per la famiglia e per la conciliazione si configuravano come sussidiarie all’intervento della famiglia, generando esiti asimmetrici sul mercato del lavoro. Poi però, a partire dagli anni 2000, il governo tedesco ha seguito una svolta “scandinava”, aumentando la fornitura di servizi per la prima infanzia e prevedendo misure universalistiche individuali (ma di questo parleremo meglio in un prossimo articolo).
In Italia, infine, l’intervento pubblico sulle politiche per la famiglia e per la conciliazione è sempre stato discontinuo e frammentato: di fatto l’attore pubblico era tradizionalmente residuale rispetto alla rete familiare. Tuttavia, nel corso degli anni ci sono state una serie di riforme che hanno introdotto delle novità come l’assegno unico universale, parte del più ampio piano di riforme noto come Family Act (al momento in fase di elaborazione dal Governo, dopo l’emanazione della Legge delega).
Facciamo il punto
Da quest’analisi, emerge come investire in politiche per la famiglia e la conciliazione non solo aiuti a contrastare la denatalità, ma garantisca anche un maggior tasso di occupazione femminile. Non solo: in base al mix di politiche che un Paese adotta, abbiamo risultati diversi in termini di natalità. Gli studi di Luci-Greulich e Thévenon (2013) suggeriscono infatti che siano soprattutto i servizi di cura di qualità e i trasferimenti monetari diretti legati alla presenza di figli a fare la differenza.
Attualmente, i tassi di fecondità più alti in Europa occidentale sono la Francia (di cui ci occuperemo in un prossimo articolo) e i Paesi scandinavi, che peraltro sono continuati a crescere anche durante la pandemia. Anche in Germania, dopo un lungo periodo con tassi di fecondità molto bassi, adesso si sta assistendo a un nuovo aumento della natalità (Figura 1). Sia i Paesi nordici che la Germania hanno puntato molto sull’assegno universalistico per i figli e sul diritto dei bambini di avere un’educazione fin dalla primissima infanzia, confermando quanto riportato dagli studi.
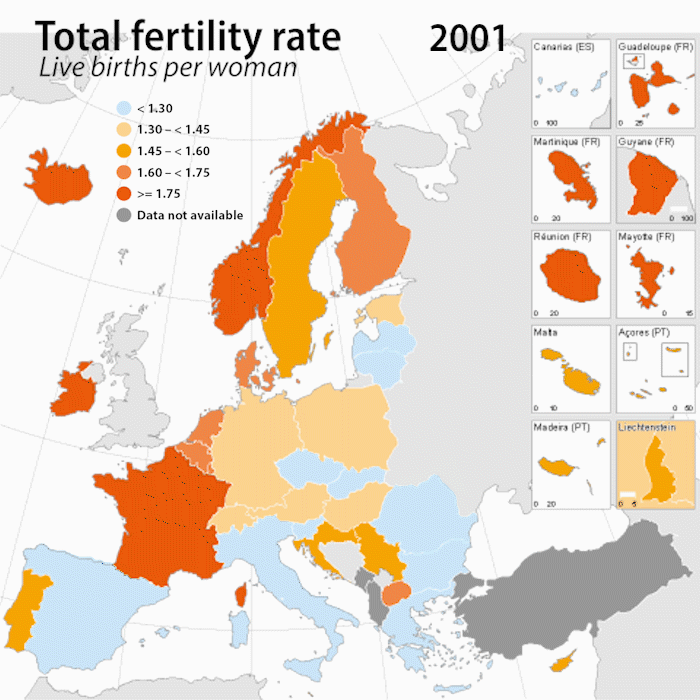
Figura 1. Tasso di fertilità in Europa (2001-2019).
Fonte: Eurostat 2021.
L’Italia (cui dedicheremo un prossimo articolo) ha, invece, sempre agito in maniera discontinua sulle politiche per la famiglia, ma la situazione potrebbe cambiare. Il Family Act (con il quale dovremmo recepire la Direttiva UE sul work-life balance del 2019) sembra voler superare questa visione, ma bisognerà aspettare ancora per osservarne l’implementazione e i risultati.
Fonte: Percorsi di Secondo Welfare