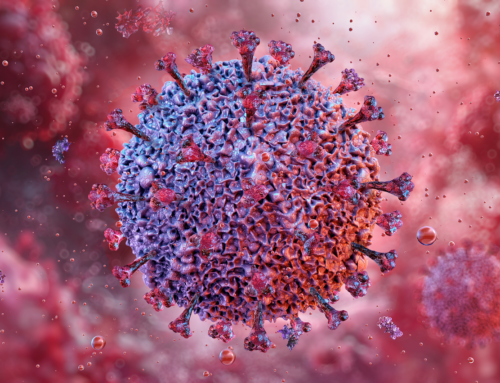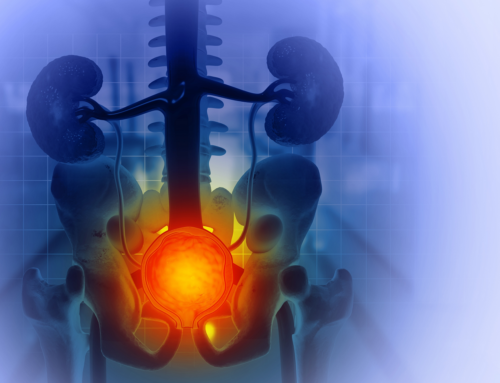Sanità italiana: quando il regionalismo diventa disuguaglianza

Articolo del 23 Aprile 2025
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nato nel 1978 con l’intento di garantire cure gratuite e universalistiche a tutti i cittadini, si trova oggi di fronte a una profonda crisi di uniformità. Alla base del problema c’è un regionalismo spinto che, pur essendo nato per rendere la sanità più efficiente e vicina ai cittadini, rischia di aver prodotto l’effetto opposto: un’Italia sanitaria a più velocità, dove la qualità delle cure dipende sempre più dal luogo di residenza.
Una sanità frammentata
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha affidato alle Regioni la competenza esclusiva sull’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Questo ha portato alla creazione di 21 sistemi sanitari distinti, ognuno con le proprie regole, priorità e livelli di investimento. Sebbene alcune Regioni abbiano dimostrato capacità gestionali elevate, molte altre – spesso quelle con maggiori fragilità economiche e sociali – si sono trovate in difficoltà, aggravando il divario Nord-Sud.
Le disuguaglianze che penalizzano i cittadini
L’effetto più diretto della frammentazione è l’iniquità nell’accesso alle cure. I cittadini di alcune Regioni godono di servizi efficienti, tempi d’attesa contenuti e strutture moderne; altri, invece, devono fare i conti con ospedali sottodimensionati, carenza di personale e attese incompatibili con il diritto alla salute. La mobilità sanitaria – ovvero il fenomeno per cui molti cittadini del Sud si spostano al Nord per curarsi – è diventata un sintomo strutturale del sistema. Oltre al disagio personale, questo fenomeno produce un drenaggio continuo di risorse finanziarie dalle Regioni più povere verso quelle più ricche, accentuando ulteriormente lo squilibrio.
Il rischio del regionalismo differenziato
Negli ultimi anni, la spinta verso un regionalismo ancora più marcato – con la richiesta di maggiore autonomia da parte di Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – ha sollevato forti preoccupazioni. Se non accompagnato da meccanismi di riequilibrio, il cosiddetto regionalismo differenziato rischia di cristallizzare le disuguaglianze, creando cittadini di serie A e serie B. In un Paese dove la salute dovrebbe essere un diritto universale, una tale prospettiva rappresenta una minaccia concreta all’unità e all’equità del SSN.
Il paradosso dell’autonomia
L’autonomia regionale, in teoria, permette di modellare i servizi sanitari sulle esigenze locali. Ma senza una regia nazionale forte e criteri uniformi, può trasformarsi in isolamento decisionale e incapacità di fare sistema. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia pericoloso avere 21 piani sanitari scollegati: la confusione iniziale tra protocolli diversi, la concorrenza tra Regioni per l’acquisto di dispositivi e vaccini, e la disomogeneità nei dati raccolti hanno evidenziato i limiti di un modello troppo frammentato.
Verso un riequilibrio
Oggi, la vera sfida è ricucire il tessuto sanitario nazionale. Serve un intervento statale più incisivo per garantire standard minimi uniformi, rafforzare la rete territoriale soprattutto nelle Regioni in difficoltà, e attivare meccanismi di perequazione che riequilibrino risorse e competenze. La salute non può essere una variabile dipendente dalla geografia, ma un diritto fondamentale per tutti.
Conclusione
Il regionalismo in sanità ha mostrato sia luci che ombre, ma quando diventa sinonimo di disuguaglianza, è necessario ripensarlo. Riaffermare una visione nazionale della salute pubblica, senza rinunciare al contributo delle autonomie locali, è l’unica via per restituire dignità ed equità al Servizio Sanitario Nazionale. In gioco non c’è solo l’efficienza del sistema, ma l’integrità stessa del patto sociale tra cittadini e istituzioni.
Per approfondimenti: ILSOLE24ORE