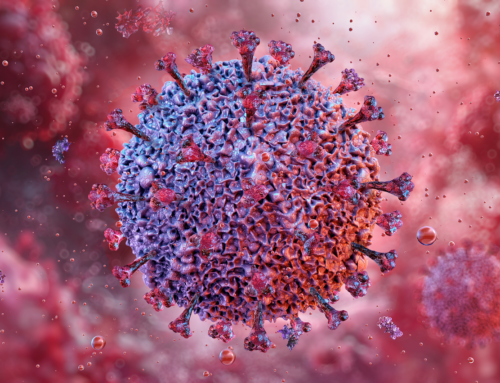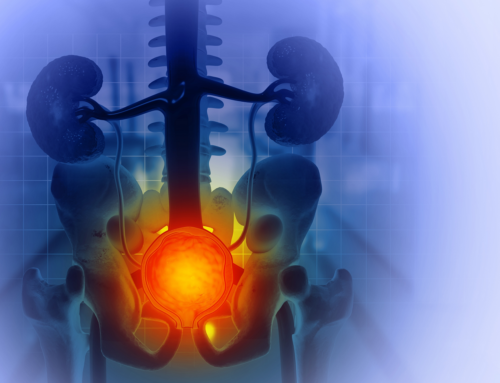Anche gli animali usano il distanziamento sociale.
Articolo del 05 Novembre 2020
L’isolamento sociale è una delle sfide più difficili cui ci ha sottoposto la pandemia di Covid-19. Non solo i mesi di confinamento della scorsa primavera, chiusi ognuno dentro le mura di casa, protettive e carnefici al contempo. Anche ora che siamo più liberi di muoverci dobbiamo tenere le distanze, evitare contatti con persone che non fanno parte della nostra quotidianità, ed è emotivamente difficile vedere una persona cara dopo tempo e non poterla abbracciare, perché gli abbracci fanno parte del modo innato con cui comunichiamo affetto e vicinanza. Ma il distanziamento sociale è una prerogativa degli umani e delle loro regolamentazioni o è una strategia evolutiva adottata dagli animali per difendersi dal contagio? Una review pubblicata su Proceedings of the Royal Society B esamina le prove scientifiche sul distanziamento sociale nel mondo animale, per comprendere come il rischio di contrarre patogeni influenzi le dinamiche di gruppo.
L’ago della bilancia
Evolutivamente parlando, le strategie adottate dalle specie per sopravvivere e tramandare i propri geni sono frutto di un bilanciamento tra costi e benefici. Le specie che vivono in gruppo sono quelle più esposte alla possibilità di un contagio, ma la decisione di evitare i conspecifici malati non è scontata, perché si tratta di bilanciare il rischi di contrarre una malattia e quelli derivanti da una rinuncia alla socialità. Rinunciare al gruppo implica infatti una maggiore suscettibilità ai predatori, oltre a un maggiore dispendio energetico.
Per esempio, è stato osservato che, in caso di diffusione dell’infezione fungina mortale white nose, molti più individui di pipistrelli della specie Myotis sodalis ibernano soli o in piccolissimi gruppi, ma la presenza del gruppo aiuta di solito a mantenere stabile la temperatura corporea durante il letargo. Mentre le aragoste spinose caraibiche, che normalmente vivono in gruppo all’interno di rifugi rocciosi, abbandonano la tana se ci sono individui contagiati dal virus PaV1, rinunciando alla sicurezza di un rifugio condiviso per non essere colpiti da un patogeno molto virulento.
L’ecologia del disgusto
Molti animali sono perfettamente in grado di riconoscere i segni di una malattia in un conspecifico o le anomalie morfologiche, e la reazione è spesso quella di tenersi alla larga. Per esempio, le femmine di babbuino verde evitano di accoppiarsi con maschi che presentano ulcere genitali dovute all’infezione di Treponema pallidum, batterio responsabile della sifilide, e gli scimpanzè poliomelitici possono essere emarginati dal gruppo a causa dello strano comportamento.
Riconoscere i sintomi di una malattia è importante per prendere le misure ed evitare il contagio. Nel caso delle malattie emergenti, non sempre i segnali sono così chiari. La strategia ottimale in questo caso sarebbe quella di aumentare le precauzioni, perché è meglio evitare un falso positivo alla malattia che stare vicino a un falso negativo e ammalarsi. Un’ipotesi è che il meccanismo di azione sia il “disgusto”. Come le prede si spostano e scelgono dove alimentarsi in modo da evitare di incontrare i predatori di cui hanno paura, così il disgusto sarebbe un meccanismo di difesa verso le malattie. E in questo caso gli studi indicano una elevata propensione da parte della nostra specie a tenersi lontani da ciò che genera ribrezzo.
Non è chiaro se gli animali provino una sensazione simile al nostro, di disgusto. Di sicuro sono in grado di percepire dei segnali (spesso di natura chimica, ma anche comportamentale) che indicano la presenza di una malattia. Nel caso delle aragoste spinose caraibiche, per esempio, il segnale sarebbe una sostanza contenuta nelle urine dei soggetti che hanno contratto il virus. Nelle api, composti odorosi e feromoni segnalano la presenza di morti o malati che vengono rimossi dall’alveare. I girini della rana toro evitano gli individui affetti da una micosi intestinale e anche in questo caso il segnale chimico rilasciato nell’acqua dai girini infetti segnalerebbe il fungo. I mandrilli sono meno propensi a toelettare animali del gruppo con infezioni al tratto gastrointestinale, e studi sperimentali indicherebbero una capacità di discernere odori che indicano la presenza di patogeni nelle feci degli individui malati.
Uno studio di lungo termine sulle dinamiche dei gruppi di gorilla di pianura in Congo suggerisce che le giovani femmine siano molto più propense a lasciare il loro gruppo di origine e avventurarsi alla ricerca di uno nuovo se il silverback (il maschio dominante) mostra chiari segni di malattia, come estese dermatiti e ulcere della pelle. In questo caso, la malattia segnalerebbe, oltre a un possibile contagio, anche una minore abilità del maschio a proteggere il suo gruppo sociale.
In alcune specie la decisione di evitare contatti sociali con animali malati dipende dall’efficienza del sistema immunitario: nel ciuffolotto messicano, gli individui con un sistema immunitario più debole sono più propensi a evitare quelli malati, e lo stesso è stato dimostrato in acquario per i pesci guppie: i maschi più suscettibili a contrarre un ectoparassita evitano comportamenti sociali di contatto con individui parassitati.
Gruppi e sottogruppi
Non necessariamente il distanziamento si traduce in esclusione o confinamento dei malati. A volte la risposta è una modulazione del tipo di interazione. Le formiche sono un esempio classico della forma più elevata di struttura sociale: sono infatti eusociali, il che indica che i singoli individui si dividono in modo perfettamente coordinato i ruoli e cooperano per il benessere della colonia, che diventa una sorta di super-organismo. La divisione dei ruoli aiuterebbe le formiche a mantenere al riparo dalle malattie la preziosa regina e le larve. È infatti molto più facile che si ammalino le formiche operaie che si avventurano alla ricerca di cibo, rispetto alle formiche che accudiscono le larve. Non solo: se la malattia arriva a colpire le “infermiere”, allora gli effetti per la colonia sono molto più gravi.
Grazie all’impiego di minuscoli chip, i mirmecologi sono in grado non solo di distinguere, ma anche di tracciare in modo dettagliato gli spostamenti e le interazioni interindividuali delle formiche. Infettando sperimentalmente alcune operaie “foraggere” con le spore del fungo Metarhizium brunneum, un patogeno comune delle formiche, i ricercatori hanno osservato una riorganizzazione delle reti di contatto, in modo da proteggere dal contagio la regina e le addette alle cure delle larve. Anche in questo caso, la malattia viene probabilmente riconosciuta attraverso segnali chimici, perché iniettare altre sostanze non patogene alle formiche non sortisce alcun effetto.
Abbiamo visto che i mandrilli sono in grado di tenersi alla larga dai membri del gruppo che sono ammalati, ma con una importante eccezione: i parenti da parte materna. Le madri, le figlie e le sorelle non si evitano tra di loro se si ammalano, anzi: una scimmia con evidenti segnali di malessere viene toelettata con ancora più cura. Quindi il legame di parentela è talmente forte e importante da superare la necessità di un distanziamento sociale, almeno nell’ambito della parentela.
Non è per sempre
Non è chiaro se i cambiamenti nell’organizzazione sociale causati da una patologia possano essere permanenti o meno. Nel caso delle aragoste spinose caraibiche si è visto che le popolazioni colpite dal virus sono in genere meno sociali rispetto a quelle mai colpite dalla malattia. Ma gli esperimenti sulle formiche e gli studi sui primati indicano che invece gli animali guariti non hanno problemi a rientrare nel gruppo e a ritornare alle normali interazioni. Proprio per i primati, che hanno società complesse, è stato teorizzato che i parassiti e i patogeni abbiano avuto un importante ruolo nell’evoluzione della stabilità dei gruppi sociali. La modulazione delle dimensioni dei gruppi in 19 specie di primati è un meccanismo di protezione dalle malattie. Per esempio, individui strettamente associati di colobi, piccole scimmie africane, hanno lo stesso microbioma gastrointestinale e le analisi dimostrano che questo non è legato all’ereditarietà o a una dieta simile, ma proprio alla presenza di maggiori contatti tra individui di uno stesso gruppo ristretto.
Non tutte le specie praticano il distanziamento sociale, ma sono moltissime quelle che in qualche modo usano la distanza per evitare il contagio. Il che indica un vantaggio evolutivo, considerati i benefici della vita di gruppo. In un’intervista su Science mag, Dana Hawley, una delle autrici della review sul distanziamento sociale negli animali, ha dichiarato: “la morale è che il distanziamento sociale funziona. È un comportamento che si è evoluto più e più volte, in specie animali non imparentate, e questo indica che i benefici superano i costi, anche se il distanziamento ha costi elevati”.
Fonte: Scienza in Rete