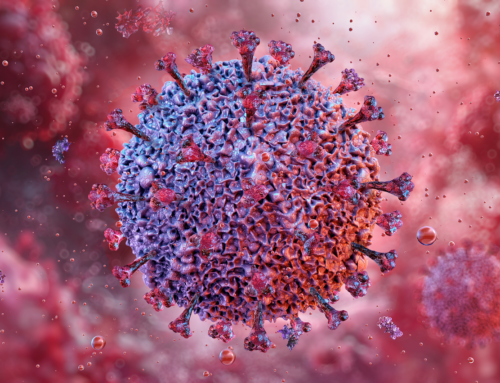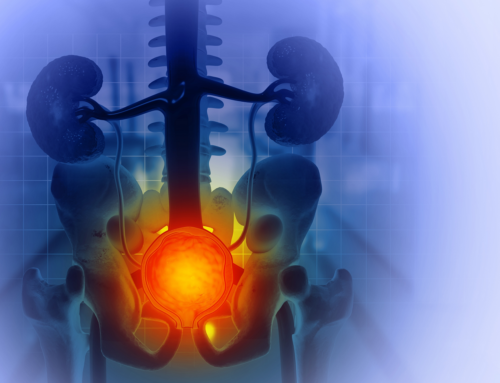Anticorpi monoclonali: tanto rumore è giustificato?
Articolo del 10 Febbraio 2021
Nelle ultime settimane ci sono state grandi polemiche, sostenute da una grande attenzione mediatica, sull’utilizzo degli anticorpi monoclonali in Italia per trattare i pazienti COVID-19 nelle fasi iniziali della malattia. Questi farmaci sono stati spesso presentati come “molto efficaci” da media, virologi, politici e portatori di interessi vari. Senza scendere nel dettaglio delle polemiche e degli eventuali interessi che potrebbero esservi associati, riteniamo sia utile ragionare sui dati disponibili per capire, date le conoscenze attuali, quale potrebbe essere il ruolo di questi farmaci nell’interesse (quello sì fondamentale) dei pazienti.
Essendo degli anticorpi, questi prodotti possono bloccare la replicazione virale nelle fasi iniziali legandosi alla proteina spike, quella che permette al virus di entrare nelle nostre cellule. Richiedono una somministrazione endovenosa in ambiente ospedaliero o ambulatoriale, anche considerando la necessità di un adeguato monitoraggio e quella di poter contrastare eventuali effetti avversi di grado severo. Al momento è stata emessa dalla Food and Drug Administration lo scorso novembre l’autorizzazione all’uso in emergenza per il farmaco bamlanivimab (Eli Lilly) al dosaggio di 700 mg e per la combinazione imdevimab e casirivimab (Regeneron). Sono gli stessi prodotti per i quali l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha dato parere favorevole il 4 febbraio e per i quali esistono pubblicazioni su riviste scientifiche con revisione fra pari.
In particolare due studi randomizzati, oltre a presentare per questi prodotti i dati sulla riduzione della carica virale, hanno presentato anche dati sulla prevenzione di ricoveri ospedalieri + accessi in pronto soccorso (senza però la possibilità di distinguere gli uni dagli altri) o nelle visite mediche. Si tratta di indicatori secondari, non in termini di importanza naturalmente: negli studi è necessario definire a priori un indicatore principale e, in base alla quantità di beneficio che si vuole mostrare, si definisce il campione di pazienti necessario. Dimostrare una riduzione nella carica virale richiede un minor numero di pazienti di quanti ne richiede la riduzione dei ricoveri, se quest’ultima non è abbastanza ampia da essere rilevata anche con un campione ridotto. Gli studi in questione hanno arruolato poche centinaia di pazienti che, anche nelle aspettative degli sponsor, evidentemente non erano sufficienti per “puntare” sui ricoveri come indicatore principale. Al momento non ci sono dati sulla riduzione della mortalità e quelli su sottogruppi di pazienti a maggior rischio sono estremamente limitati.
Vediamo i dati: nello studio pubblicato il 21 gennaio su JAMA il bamlanivimab alla dose di 700 mg, somministrato a 101 pazienti ambulatoriali con tampone positivo e sintomi lievi o moderati, non ha ridotto in modo statisticamente significativo la carica virale rispetto al placebo. C’è stata una riduzione numerica, ma anche in questo caso statisticamente non significativa, dell’indicatore combinato ricoveri + accessi in pronto soccorso entro 29 giorni: 5,8% nel gruppo placebo rispetto a 1% nel gruppo bamlanivimab 700 mg. In termini assoluti, una riduzione di quasi 5 pazienti ricoverati ogni 100 trattati, ma in termini relativi l’efficacia può essere – ed è stata – presentata in una luce più favorevole come superiore all’80% (4,8% in meno rispetto a un rischio di base del 5,8%). Sempre ragionando in termini assoluti, se questa riduzione fosse statisticamente significativa (se cioè fossimo abbastanza fiduciosi che non sia dovuta al caso) indicherebbe mediamente un ricovero in meno per ogni 21 pazienti trattati.
Per quanto riguarda la combinazione imdevimab + casirivimab, l’altro studio (anche questo pubblicato il 21 gennaio, ma sul New England Journal of Medicine) ha mostrato una riduzione statisticamente significativa nella carica virale ma non nelle visite mediche: a 28 giorni queste ultime sono risultate del 6% nel gruppo placebo rispetto a 3% tra i 182 pazienti assegnati al farmaco. In termini assoluti, 3% in meno; in termini relativi la metà (50%) in meno. Se questa riduzione fosse statisticamente significativa, indicherebbe mediamente una visita medica in meno per ogni 33 pazienti trattati.
Va detto che esiste un grande bisogno di farmaci efficaci, in particolare nei pazienti a domicilio a rischio di evoluzione della malattia e che potrebbero necessitare di ricovero in ospedale o in terapia intensiva, e ciò porta a riporre grandi speranze in prodotti che potrebbero avere i presupposti per evitare tale evoluzione. Casi aneddotici riportati dai media, come quello di Donald Trump, aumentano interesse e speranze legate a terapie come queste, nonostante i costi molto elevati, le difficoltà di produzione e di gestione di trattamenti che richiedono strutture dedicate, tempestività di azione e che dovrebbero essere accessibili a tutti coloro che eventualmente ne potrebbero beneficiare. Ma più che a casi aneddotici bisognerebbe guardare ai dati di studi rigorosamente controllati e (possibilmente) condotti su ampie casistiche.
E i dati attualmente disponibili non sono, obiettivamente, granché favorevoli: le riduzioni numeriche viste prima sono piccole, su casistiche limitate e potrebbero essere frutto del caso, non essendo tutte statisticamente significative (soprattutto quelle clinicamente più importanti). Per questo i National Institutes of Health negli Stati Uniti evidenziano che non ci sono dati sufficienti per raccomandare a favore o contro questi prodotti, che comunque non dovrebbero essere considerati come terapia standard. Da parte sua, la Infectious Diseases Society of America raccomanda esplicitamente contro l’uso di routine di bamlanivimab in pazienti ambulatoriali e specifica che il farmaco rappresenta un’opzione se il paziente, adeguatamente informato, conferisce maggior valore ai potenziali benefici rispetto ai potenziali rischi, considerando l’incertezza esistente sugli uni e sugli altri.
Sorprende come questi prodotti, che si spererebbe di utilizzare in modo estensivo nella pratica clinica su una malattia purtroppo ad ampia diffusione, siano attualmente stati studiati solo su poche centinaia di pazienti, anche considerando che (secondo i rumors mediatici) la Eli Lilly avrebbe proposto di regalare all’Italia 10.000 dosi di bamlanivimab da utilizzare in una sperimentazione. C’è da sperare che ulteriori ricerche possano definire meglio e in senso più favorevole il profilo di efficacia e di sicurezza di questi farmaci, indicando anche se possano avere un impatto sulla mortalità. Proprio per questo sarebbe opportuno riservare il loro utilizzo nell’ambito di studi randomizzati (come quello bandito dalla stessa AIFA). Per ora dunque si dovrebbe fare attenzione a stanziare somme ingenti (500 milioni di euro) per queste terapie, come sottolineato nell’editoriale di Giovanni Rodriquez.
C’è anche da sperare che non si approfitti di questo polverone, che sembra sollevato ad arte, per far prevalere interessi di parte e apportare ingiustificate modifiche al governo della sanità. E c’è infine da sperare che i media non si prestino ad interessi che non siano quelli della corretta informazione e che possano abituarsi (e abituare i propri lettori) all’uso di dati presentati in modo trasparente. Dire infatti che questi farmaci sono efficaci al 70-80% significa gettare fumo negli occhi usando dati di riduzioni relative su un rischio di base basso, classico trucchetto utilizzato da chi vuole vendere i propri prodotti. Bisognerà piuttosto evidenziare (se e quando il dato ci sarà e sarà consolidato) quanti saranno in assoluto i ricoveri e anche le morti evitate per ogni 100 persone trattate. Altrimenti si fa solo del rumore non utile a capire e non nell’interesse della sanità pubblica.
Fonte: QuotidianoSanità.it