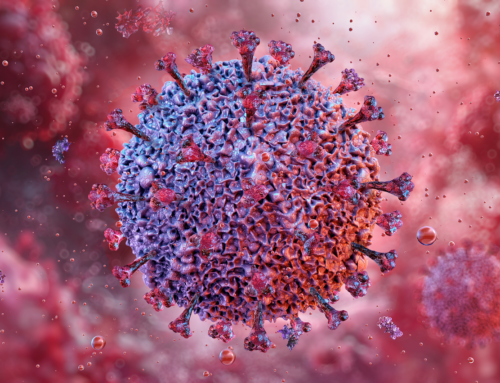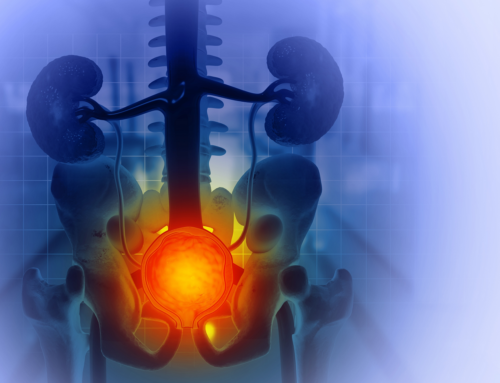Anticorpi ribelli all’origine delle forme gravi di covid?
Articolo del 08 Febbraio 2021
Se come esseri umani possiamo produrre musica, e non solo con le corde vocali, lo dobbiamo al cervello. Ma il percorso per riuscirci è stato lungo e complesso.
Il canto è uno dei comportamenti più affascinanti emersi nel corso dell’evoluzione. Uccelli, balene, scimmie e tantissimi altri animali si impegnano in sofisticatissimi vocalizzi, molti dei quali veicolano segnali comunicativi ben precisi. Esistono i cinguettii di corteggiamento, gli ululati che fungono da Gps naturale per il branco, le grida e le urla di pericolo, fino alla ninnananna che la mamma umana canta sottovoce al suo cucciolo. Il canto produce musica e noi, Homo sapiens, nel corso della storia siamo stati in grado di separare questi due elementi, riuscendo a produrre musica attraverso le tecniche più disparate. Non solo corde vocali, ma corde di metallo, percussioni, trombe, tastiere… software! Cosa ci ha consentito di raggiungere tali traguardi?
Esattamente lo stesso strumento grigiastro e spugnoso che ci ha permesso di raggiungere tutti gli altri: il cervello. Per approfondire i suoi legami con la musica, abbiamo fatto qualche domanda alla professoressa di psicobiologia e psicologia fisiologica Alice Mado Proverbio, autrice di Neuroscienze cognitive della musica. Il cervello musicale tra arte e scienza (2019, Zanichelli Editore).
Un vantaggio evolutivo?
Iniziamo con una domanda sulle origini di queste attività: quali sono state le spinte evolutive alla produzione del canto e della musica in Homo sapiens? Sappiamo che negli uccelli, ad esempio, il cinguettio è uno strumento di selezione sessuale…
“Si ritiene che il cervello umano sia plasmato sulla possibilità di utilizzare suoni musicali per comunicare attraverso il canto, prima ancora che attraverso il linguaggio uditivo/verbale (prerogativa dei sapiens)” – afferma la studiosa. “Sembra che Homo neanderthalensis utilizzasse un proto-linguaggio composto da vocalizzazioni intonate musicalmente (canzoni stereotipate) per trasmettere stati d’animo, indurre determinati comportamenti negli altri e condividere informazioni utili alla caccia, alla raccolta del cibo o ad altri comportamenti di gruppo e sociali”, conclude.
Insomma, sia i nostri antenati che altre specie umane si servivano del canto e della musica per comunicare, per influenzare gli altri e per ottimizzare la gestione della loro vita quotidiana. Nei sapiens l’emergere del linguaggio articolato ha poi aperto a una miriade di possibilità canore e musicali, le quali rispecchiavano, in qualche modo, l’altrettanto massiccio sviluppo cerebrale.
Aree cerebrali coinvolte
Nel concreto del nostro cervello di oggi, dunque: cosa accade quando suoniamo uno strumento?
“Anzitutto viene stimolata la corteccia occipito/temporale per la lettura delle note – chiarisce la studiosa – In seguito, attraverso la via dorsale e la corteccia parietale, l’informazione semantica dello spartito (tipologia di note, struttura ritmica, etc.) si converte in informazione motoria (modalità di esecuzione effettiva). La corteccia premotoria programma, dapprima grossolanamente e via via sempre più nel dettaglio, tutti i movimenti a partire da 500 ms prima della loro esecuzione.”
Bisogna distinguere però – sottolinea Proverbio – “i movimenti super appresi (scale, arpeggi, trilli, etc.), i quali vengono eseguiti in automatico dall’area supplementare motoria, dai movimenti in fase di studio: quest’ultimi vengono controllati on-line con l’aiuto della vista e dell’udito (STG) dalla corteccia premotoria laterale. Nell’esecuzione sono poi coinvolte altre strutture, come il cervelletto, i gangli della base e il corpo calloso. Fondamentali sono infine le strutture deputate alla memoria e alla rappresentazione a breve termine, quindi la corteccia prefrontale e l’ippocampo. Basti pensare che il cervello di un musicista è in grado di ricordare milioni di note musicali, di produrre 1200 movimenti al minuto”.
Quando si ascolta la musica invece, cosa accade?
Esistono due stadi della codifica, spiega la neuroscienziata. Il primo è dedicato “all’analisi del suono, il secondo al riconoscimento della musica. Durante la prima fase sono coinvolti i recettori dell’orecchio interno, i quali trasformano gli stimoli meccanici del suono in informazioni bioelettriche e li inviano al nervo acustico. In seguito avviene la codifica della posizione spaziale della fonte sonora, nel tronco encefalico, poi delle ulteriori caratteristiche del suono, nel talamo, e infine la corteccia uditiva primaria analizza gli intervalli di frequenza e il timbro”.
“Nel secondo stadio – prosegue Proverbio – il cervello riconosce le melodie, le musiche preferite, le associa a ricordi più o meno piacevoli, coinvolgendo le regioni associative della corteccia temporale superiore, insieme all’ippocampo, al sistema limbico e all’amigdala.” Dipende poi se la musica piace o no – incalza la studiosa – “nel primo caso si attiva il sistema dopaminergico di ricompensa e il centro del piacere (nucleo accumbens). Si ritiene che ritmi complessi e la musica dissonante stimolino maggiormente l’emisfero sinistro, mentre le melodie e gli accordi armonici attiverebbero maggiormente le aree uditive destre”.
Consonanza e dissonanza, fisiologia ed estetica
Proprio a proposito di consonanze e dissonanze: tali reazioni psicofisiologiche a specifiche qualità armoniche, sono innate o culturalmente variabili? “Si ritiene che la discriminazione tra intervalli consonanti/dissonanti avvenga indipendentemente dalla cultura di appartenenza” – rivela Proverbio. “La percezione di fastidio/ruvidezza causata dalla dissonanza può conseguire da ragioni puramente fisiologiche: è infatti rilevabile nel neonato di 3 giorni, nell’essere umano adulto, come in altre specie di primati (macachi).
Dobbiamo però evidenziare – riprende la scienziata – che la familiarità a un certo stile e l’educazione musicale possono modificare le sensazioni estetiche derivanti da questi suoni. Per esempio i musicisti professionisti sembrano gradire la musica di Schönberg molto più intensamente di ascoltatori naïve, poiché posseggono strutture corticali uditive associative in grado di riconoscere strutture armoniche e melodiche “nascoste” ai più, in grado di stimolare il piacere estetico”. Questo può essere un interessante esempio di come la musica, in maniera analoga ad altre forme d’arte, può addirittura modificare alcuni circuiti cerebrali.
In ogni modo, siamo entrati senza saperlo nel fascinosissimo campo della neuroestetica, una disciplina di frontiera che unisce le neuroscienze, l’estetica e l’arte. Grazie a studi in questo settore sappiamo ad esempio, rivela Proverbio, che sono tanto più apprezzabili gli stili di musica caratterizzati da dissonanza (come spesso accade nel Jazz), quanto più si è musicalmente esperti o frequentemente esposti a tali stili.
È così che arte e biologia si spogliano delle loro differenze e si fondono in un connubio inscindibile, la cui matrice è il nostro cervello. Due mondi che sono sempre stati arbitrariamente separati vivono in realtà un forte rapporto bidirezionale. Decine di migliaia di anni fa gli antichi sapiens svilupparono circuiti cerebrali che diedero avvio a questa forma d’arte: la musica. Come ogni prodotto della cultura umana, però, anch’essa a un certo punto iniziò a vivere di vita propria, modificando a sua volta l’uomo e la sua stessa biologia. Cervello e musica non sono dunque una questione di “natura o cultura”, bensì di “natura e cultura”.
Fonte: Oggi Scienza