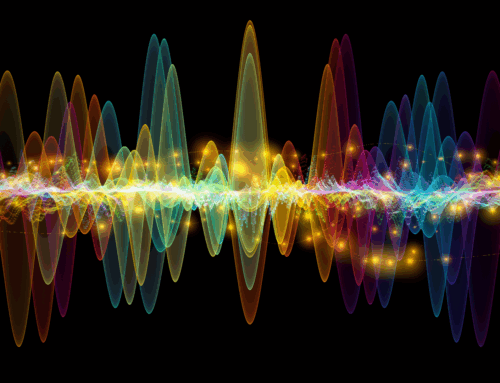Quasi la metà delle terre del pianeta è degradata
Articolo del 16 Maggio 2022
Il rischio è di perdere un’area grande quanto il Sud America entro metà secolo. Lo annuncia un recente rapporto delle Nazioni Unite che identifica nell’agricoltura la causa principale, ma che indica anche scenari per invertire la rotta tenendo conto del valore economico del capitale naturale.

È tra le più gravi minacce che l’uomo dovrà affrontare nei prossimi decenni e l’ulteriore conferma che il cosiddetto business as usual ha già raggiunto e in alcuni casi superato ampiamente i limiti planetari. Il 40 per cento delle terre del pianeta, infatti, è degradato. In altre parole, l’uomo ha modificato le caratteristiche biofisiche di quasi la metà del suolo terrestre, a causa principalmente dell’agricoltura: la filiera agroalimentare è responsabile dell’80 per cento della deforestazione e del 70 per cento dell’uso di acqua a livello globale.
Sono questi i punti principali evidenziati dal Global Land Outlook 2, pubblicato di recente dalla Convenzione contro la desertificazione delle Nazioni Unite (UNCCD). Si tratta di un rapporto realizzato grazie a cinque anni di lavoro e che raccoglie più di un migliaio di studi scientifici sul tema e che precede i lavori della COP15 che si terrà in Costa d’Avorio, tra il 9 e il 20 maggio 2022.
Secondo Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell’UNCCD: “L’agricoltura moderna ha alterato la superficie del pianeta più di qualsiasi altra attività umana. Dobbiamo ripensare urgentemente ai nostri sistemi alimentari globali”. Il sistema agroalimentare è infatti oggi responsabile di circa un terzo delle emissioni globali di CO2, ma è allo stesso tempo estremamente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, come l’aumento delle temperature e la modifica dei regimi pluviometrici, che diventano sempre più irregolari.
Come sottolineato dal rapporto, ma anche dai commenti dell’UNCCD, il punto essenziale, spesso non considerato dal business as usual, è che suolo, acqua e biodiversità sono le fondamenta per il benessere e la ricchezza economica della nostra società. Un punto che nell’ambito della riqualificazione ambientale, la cosiddetta restoration ecology, è ampiamente condiviso e che mostra quale sia il reale valore, non solo economico, del capitale naturale. Si stima infatti che metà della produzione economica globale, ovvero circa 44.000 miliardi di dollari, sia indissolubilmente dipendente da questo, nonostante governi, mercati e gruppi industriali raramente ne comprendano il valore.
Un “capitale” dunque prodotto da tutti quei servizi che la natura fornisce non solo alla specie umana, ma anche a tutti gli organismi viventi del pianeta. Tuttavia il rapporto lascia ben intendere che se le tendenze attuali dovessero continuare, il rischio di cambiamenti ambientali diffusi e irreversibili saranno più probabili. E le previsioni non sono certo confortanti, dato che se le attività umane dovessero continuare come ora, entro il 2050 si prevede un ulteriore degrado di un’area grande quasi quanto il Sud America. “La trasformazione dell’agricoltura è il più grande tesoro non sfruttato del pianeta per far fronte alla crisi climatica”, ha confermato a “Le Scienze” il professor Thomas Elmqvist, del Stockholm Resilience Center e uno degli autori della prima analisi scientifica della Europe’s National Academies of Sciences (EASAC) sul potenziale dell’agricoltura rigenerativa: “L’odierna agricoltura convenzionale su larga scala ha un enorme impatto negativo sul suolo. L’erosione del suolo, la perdita di flora e fauna e quindi di nutrienti nei suoli, è diventato un fattore importante in Europa”.
I risultati dell’EASAC mostrano che molte delle pratiche analizzate hanno numerose sinergie tra la cattura e lo stoccaggio del carbonio e il miglioramento della biodiversità, pur non avendo grandi effetti negativi sulla produzione alimentare a lungo termine. Gli scienziati sottolineano che l’agricoltura rigenerativa non contraddice l’uso delle moderne tecnologie di allevamento di piante e animali, la lavorazione del terreno, l’uso di fertilizzanti minerali o pesticidi. Punta invece a un uso limitato e più mirato. L’uso di pesticidi chimici, per esempio, potrebbe essere ridotto usando alternative biologiche, impiegando colture geneticamente modificate resistenti ai patogeni o introducendo predatori.
I tre scenari del rapporto
Il Global Land Outlook 2 dipinge essenzialmente tre scenari al 2050, valutandone gli effetti sul clima, sull’economia e sulla produttività agricola. Il primo, quello basato sul continuo sfruttamento delle risorse, spinto da una crescente domanda di cibo, bioenergia, mangimi e fibre, porterebbe a una riduzione della produttività vegetale del 12-14 per cento dei terreni agricoli, dei pascoli e delle aree naturali, con l’Africa subsahariana tra le aree più colpite. Non solo, verrebbero emesse ulteriori 69 gigatonnellate di CO2, ovvero il 17 per cento delle attuali emissioni annuali di gas serra.
C’è poi lo scenario che contempla il ripristino di circa cinque miliardi di ettari di terre (il 35 per cento della superficie terrestre), attraverso l’agroforestazione, la gestione dei pascoli e la rigenerazione dei suoli. Ciò comporterebbe un aumento dei raccolti del 5-10 per cento nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, con una capacità di cattura della CO2 di 17 gigatonnellate e un ridotto tasso di perdita della biodiversità.
Lo scenario migliore è quello che considera sia il ripristino che la protezione di intere aree della superficie terrestre, almeno quattro milioni di chilometri quadrati (India e Pakistan insieme) e lo valuta in termini economici: investire in dieci anni una cifra di 1600 miliardi tolta ai 700 miliardi di investimenti l’anno sui combustibili fossili, garantirebbe un ritorno di 125.000-140.000 miliardi dollari ogni anno, ovvero il 50 per cento in più del prodotto interno lordo globale del 2021. Un investimento che certamente qualche broker considererebbe più che redditizio.

Schema dell’evoluzione dei tre scenari ipotizzate
“L’idea di fondo è che non basta più conservare gli ecosistemi rimasti integri, non basta gestire in maniera sostenibile l’agricoltura e la silvicultura, ma dovremmo lasciare una parte del territorio alle dinamiche naturali”, spiega a “Le Scienze” Gianluca Piovesan, professore al Dipartimento di agricoltura e foreste all’Università della Tuscia. “A quel punto sarà necessario decidere se portare queste aree a produttività di risorse naturali o agganciarle ad aree ad alta conservazione.”
In questo caso è fondamentale valutare i tempi di recupero funzionale delle aree naturali, siano esse foreste tropicali, savane o aree umide, dato che “il problema di base è definire quando un ecosistema è in uno stato degradato e quando l’intervento di recupero attivo risulta importante”, continua Piovesan. “Inoltre, un altro aspetto centrale è quando il recupero funzionale di un ecosistema può essere considerato raggiunto, dato che la pianificazione ecologica deve coniugare gli spazi della conservazione con quelli dell’uso sostenibile delle risorse naturali.”
Lo stato del capitale naturale nel nostro paese
Ad aprile 2021, in occasione del decennio delle Nazioni Unite per la riqualificazione ambientale, il nostro paese ha pubblicato il Quarto rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia dove si legge come la volontà del Comitato Capitale Naturale sia quella di essere: “La prima generazione che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato migliore di quello che ha ereditato” individuando come data di partenza il 2020 e dandosi l’obiettivo di ottenere, entro il 2030, lo stop alla perdita di biodiversità, l’inversione dei processi di degrado e i primi risultati di una grande “opera pubblica” di ripristino degli ambienti terrestri e marini.
Un impegno gravoso certo, ma dichiarato come prioritario anche dall’Europa, tanto che nei sei pilastri del Next Generation EU è previsto che i singoli Stati dedichino il 37 per cento delle risorse messe in campo ad azioni per il clima, l’adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità.
Nell’allegato del rapporto destinato ai decisori politici si sottolinea come gli ecosistemi a elevato rischio certificati siano 29, pari a circa il 20 per cento del territorio nazionale. La situazione più critica è presente nelle ecoregioni Padana e Adriatica, nelle quali tutti gli ecosistemi sono a rischio. In questo caso viene suggerito di recuperare e ripristinare gli ecosistemi costieri, gli ecosistemi legati ai sistemi igrofili e quelli residuali delle pianure ad agricoltura e zootecnia intensiva, di riportare la natura in città con la messa a dimora di milioni di alberi e promuovere il recupero e la riqualificazione territoriale nei sistemi agricoli intensivi riattivando le dinamiche forestali naturali.
Viene inoltre analizzata la variazione dei servizi ecosistemici in un ciclo di sei anni (2012-2018), registrando una diminuzione nel flusso di molti di essi con ripercussioni negative sui valori economici che ne dipendono: 72 milioni di metri cubi in meno di risorsa idrica ricaricata nelle falde, fino a 146 milioni di euro di perdite economiche associate all’incremento di erosione dei suoli, oltre a una perdita che varia tra i 491 e i 614 milioni di euro a causa della variazione di uso e copertura del suolo, solo per citarne alcuni.
Il prossimo decennio sarà dunque fondamentale non solo per invertire un processo che sta degradando specie, suoli e oceani, ma anche per adottare politiche mirate. “Progettando un programma di ripristino del territorio innovativo e personalizzato che si adatta alle loro esigenze, capacità e circostanze”, spiega Johns Muleso Kharika, responsabile scientifico dell’UNCCD, “i paesi e le comunità possono recuperare le risorse naturali perdute e prepararsi meglio al cambiamento climatico e ad altre minacce incombenti”.
Fonte: Le Scienze