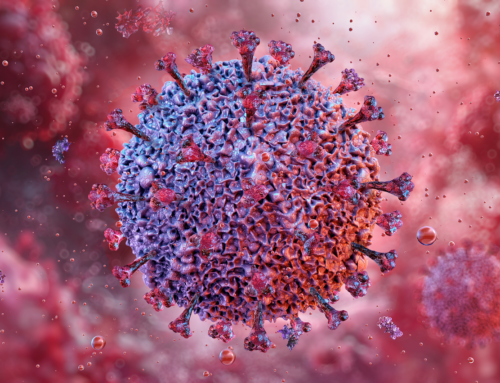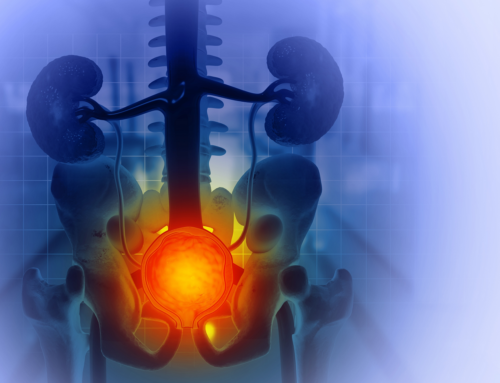Terza ondata del virus vicina: 5 verità scomode
Articolo del 04 Marzo 2021
Inseguiamo gli effetti dell’epidemia con dati vecchi e poco affidabili, senza un tracciamento efficace e con misure di contrasto spesso insufficienti. I vaccini da soli non risolveranno il problema nel breve periodo.
La crescita dei numeri del contagio che stiamo registrando da qualche giorno era prevedibile, come abbiamo scritto più volte. La campagna vaccinale da sola, peraltro condizionata dal ritardo nella consegna delle dosi, non basterà per frenare il contagio nel prossimo mese. Le misure di contrasto che mettiamo in campo sono la reazione a quanto accaduto nel passato, e lasciamo che sia il virus a imporre le proprie regole.
Le continue riaperture di attività a rischio, ampiamente dimostrata da studi condotti a livello internazionale, ravvivano il fuoco del contagio proprio quando siamo sul punto di spegnerlo. La comunicazione bonaria e rassicurante, dietro alla quale si nascondono verità scomode, ma che sarebbe utile conoscere, crea un’immagine distorta del rischio reale che l’intero Paese sta correndo.
Ci limiteremo, in questa analisi, a 5 punti chiave scelti tra i molti che potrebbero essere sottolineati per fotografare in modo corretto la situazione dell’epidemia in Italia: 5 punti che riteniamo i più importanti tra tutti quelli che, ormai da un anno e senza interruzioni, affrontiamo con i commenti quotidiani e con gli approfondimenti settimanali. Abbiamo sempre cercato di esporre la situazione in modo chiaro e sincero, senza nascondere la realtà anche quando, come è accaduto più volte, era scomoda da raccontare e da ascoltare.
1) La ripresa del contagio era scritta nei numeri
Questa volta, a differenza di quanto accaduto un anno fa, la scusante del “siamo stati sorpresi alle spalle” non regge. I segnali di un imminente ripresa del contagio c’erano tutti, da tempo. Che l’equilibrio apparentemente raggiunto fosse precario, e destinato a rompersi alla prima discontinuità negativa, lo avevamo segnalato già alla fine dello scorso anno. E nelle ultime due settimane eravamo stati ancora più espliciti, arrivando a indicare in alcune tra le Regioni più popolose, come Lombardia ed Emilia Romagna, il potenziale motore di una ripresa epidemica su larga scala. Le cose sono andate esattamente in quella direzione: non per nostre capacità divinatorie, ma per la logica conseguenza di quello che i numeri stavano esprimendo in modo molto evidente.
Chiariamolo subito: non c’è nessun accanimento con la Regione Lombardia o, come vedremo, con Emilia Romagna, Veneto, Campania e altre ancora. Il fatto che l’attenzione si concentri su queste Regioni è legata a una considerazione molto semplice: non tutte le Regioni sono uguali, dal punto di vista della popolazione residente. Se utilizziamo i dati Istat (pubblicazione del 15 dicembre 2020) vediamo che esistono distanze enormi tra i numeri espressi. La Valle d’Aosta, con 125.000 abitanti, è lontana anni luce dai 5.700.000 di Lazio e Campania e ancora di più dai 10 milioni della Lombardia. E lo stesso vale per Molise (300.000) e Basilicata (553.000). Messe tutte insieme Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non raggiungono i due terzi degli abitanti della sola Milano.
In altri termini: ovunque si manifesti una ripresa dell’epidemia abbiamo un problema: ma quando accade nelle Regioni più abitate il problema diventa enorme, con ricadute immediate sui numeri nazionali. La sola Lombardia, che infatti teniamo monitorata in modo costante, rappresenta un sesto della popolazione italiana. Questo aspetto, ossia il peso relativo delle singole aree sul totale nazionale, viene spesso trascurato o comunque lasciato annegare nella grande cornucopia dei dati quotidiani, che ogni giorno trabocca di numeri che restano fini a sé stessi senza una corretta valutazione.
Quindi, in modo esplicito, se abbiamo un problema in Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Veneto, solo per fare un esempio, stiamo avendo un problema che automaticamente coinvolge 25 milioni di persone, il 42% della popolazione italiana. Ebbene, il problema nelle scorse settimane si è evidenziato proprio in queste Regioni, senza per questo voler trascurare la situazione in altre aree del Paese.
Ma l’attribuzione delle fasce di rischio, parametrata ogni venerdì su dati che risalgono ad almeno una settimana prima (ne riparleremo più avanti) ha dato una risposta tardiva: abbinando di fatto le restrizioni a una situazione epidemiologica ormai passata, con il virus ancora libero di proseguire la sua corsa.
Partiamo dalla Lombardia, entrata in zona arancione da inizio marzo. La dinamica del contagio era molto evidente. La prima inversione di tendenza nel numero dei nuovi casi risale infatti alla prima settimana epidemiologica completa di febbraio (6-12 febbraio) quando il numero dei positivi era salito a quota 12.767 segnando un +13,3% sui sette giorni precedenti. Troppo poco per intervenire? Ammettiamo pure di sì, ribadendo parallelamente che per sconfiggere un’epidemia la si deve anticipare e non inseguire.
La settimana successiva (13-19 febbraio) un nuovo incremento: 14.933 nuovi casi, +16,9%. Nella terza settimana (20-26 febbraio) i nuovi casi sono balzati a 21.614 (+44,7%) e solo a quel punto è stato deciso il passaggio di colore, da giallo ad arancione: ma la decisione è stata presa non sugli ultimi dati disponibili, bensì su quelli contenuti nel Report settimanale che fotografava la situazione relativa alla seconda delle tre settimane da noi indicate.
È vero che nel frattempo sono state istituite zone rosse su base locale, o zone di “arancione rafforzato”: ma in presenza di una variante virale con una capacità infettante del 40% superiore rispetto al virus di Wuhan il contagio ha continuato a crescere. E infatti i numeri della terza settimana, già disponibili ma non ancora consolidati nel Report ufficiale quando è stato deciso il passaggio da zona gialla ad arancione, riportano quel balzo del 44,7% che abbiamo sottolineato prima. I primi 4 giorni della settimana epidemiologica in corso (27 febbraio – 2 marzo) stanno segnando un ulteriore rialzo del 30,2% con 13.617 nuovi casi contro 9.504: nella valutazione ufficiale, e nei relativi interventi, con le regole attualmente in vigore vedremo questi numeri presi in considerazione solo nelle prossime settimane.
Nel frattempo, dalla Provincia di Brescia, la ripresa dell’infezione ha coinvolto Como, Varese, Monza-Brianza e Milano: nel capoluogo lombardo, nelle ultime due settimane, i numeri stanno aumentando con una dinamica superiore al 40%. Ma la zona gialla è rimasta, intoccabile, fino alla scorsa domenica.
Dopo questo lungo dettaglio dedicato alla Lombardia, passiamo ad altre Regioni altamente popolate e con numeri che non lasciano intuire settimane di tranquillità.
In Emilia Romagna la dinamica è molto simile a quella della Lombardia: Al +8,5% della settimana epidemiologica 13-19 febbraio, con 9.581 nuovi casi, è seguita una settimana (20-26 febbraio) di forte rialzo: +36,7% con 13.103 nuovi casi. E i primi 4 giorni della settimana epidemiologica in corso disegnano una curva in crescita del 39,6%.
La ripresa dell’epidemia si è manifestata con tempi diversi, ritardati di una settimana, anche in altre Regioni: in Campania, per esempio, dove il rallentamento registrato nel periodo 13-19 febbraio (-8,3% con 8.908 nuovi casi) ha subito una brusca inversione la settimana successiva (20-26 febbraio) chiusa con 13.062 positivi e un rialzo del 46,6%. I primi 4 giorni della settimana epidemiologica in corso segnalano una crescita del 45,9%.
Tempistica del contagio molto simile anche in Veneto: al calo del 10,2% del periodo 13-19 febbraio ha fatto seguito un’impennata (+61,5% con 6.906 nuovi casi) tra il 20 e il 26 febbraio, mentre i primi 4 giorni del periodo epidemiologico in corso (ricordiamo 27 febbraio – 2 marzo) segnano un rialzo più contenuto (+12,2%).
Risulta evidente lo sfasamento tra il periodo preso in considerazione per valutare le misure di contrasto e quello più recente, che apparirà nelle valutazioni ufficiali solo alla fine di questa settimana. È impossibile fare diversamente? No, e avanziamo un suggerimento: considerare l’andamento dei nuovi casi per settimana mobile permette di osservare l’andamento dell’epidemia (fase di espansione o di contrazione) giorno per giorno. E non si tratta di dati astrusi o errati: sono esattamente quelli sulla cui base vengono poi elaborati i dati ufficiali.
Insomma, bisogna trovare un modo per giocare d’anticipo: inseguire è inutile, soprattutto adesso che il virus è diventato, grazie alle varianti, ancora più veloce. Ricordiamo in proposito che la variante inglese, secondo le elaborazioni dell’Iss, già lo scorso 18 febbraio rappresentava il 54% delle nuove infezioni nel nostro Paese.
2) Senza tracciamento e con dati inaffidabili procediamo con molte difficoltà
Su questi due temi abbiamo più volte espresso molte perplessità. Anche a inizio anno avevamo ricordato come senza una corretta valutazione della circolazione del virus gli allentamenti avrebbero comportato un rischio elevato di ripresa dell’infezione.Partiamo dal tracciamento, o contact tracing: il nostro livello di guardia, più volte ribadito dall’Iss, è di 50 nuovi casi per 100.000 abitanti nell’arco di una settimana. Questo dato, riportato per semplicità a un numero quotidiano, corrisponde a 4.311 nuovi casi di media giornaliera a livello nazionale. Un valore che indichiamo ogni giorno, nel commento ai numeri, come target da raggiungere.
Il problema è che si tratta di un valore che abbiamo “quasi” toccato per l’ultima volta, senza nemmeno più riuscire ad avvicinarlo, lo scorso 12 ottobre (4.619 positivi). In altri termini, da quasi 5 mesi viaggiamo su valori doppi, tripli, o quadrupli rispetto al livello massimo sostenibile, con un picco di quasi 10 volte raggiunto il 13 novembre (40.902 positivi).
Senza tracciare il virus sul territorio è impossibile sconfiggerlo: si raggiunge al massimo un equilibrio delicatissimo, come infatti è accaduto, su livelli di contagio molto elevati. Che comporta come conseguenza un costante afflusso di ricoverati e di decessi: i valori sui quali ci siamo attestati da qualche settimana, tra le 300 e le 400 vittime, corrispondono agli effetti della ripetizione, ogni 2-3 giorni, di un terremoto devastante come quello che ha colpito il Friuli nel 1976. Oppure, ogni giorno, di un terremoto come quello dell’Aquila del 2009.
Il contact tracing, in queste condizioni di assoluta inadeguatezza, non può essere efficace: perché i contatti devono essere rintracciati entro un massimo di 48-72 ore. Arrivare più tardi significa raccogliere dati buoni per la statistica, ma inutili per bloccare la diffusione del virus.
A questo problema si somma l’annosa questione dei tamponi: fino all’inizio dello scorso novembre il numero dei test eseguiti nel nostro Paese (tutti molecolari) è stato in costante crescita. Fino a toccare un massimo quotidiano di 254.908 il 13 novembre del 2020, all’interno di un range costantemente superiore ai 200.000, e di poco inferiore nel fine settimana.
Dopo l’introduzione delle fasce di rischio, con restrizioni e allentamenti pronti a scattare in modo automatico al di sopra o al di sotto di soglie prefissate, il numero dei tamponi è letteralmente crollato: scendendo, nel fine settimana, anche sotto quota 100.000, e complessivamente riducendosi del 50% circa rispetto ai valori massimi. Un caso, oppure una strategia voluta di minore controllo per avere numeri più bassi e ottenere allentamenti? Non rispondiamo: restano i numeri a indicare con precisione la dinamica di quei mesi.
A invertire la rotta, almeno in apparenza, è intervenuta la decisione di includere nel conteggio totale dei test eseguiti, a partire dal 15 gennaio 2021, anche i tamponi antigienici rapidi. Scelta in teoria corretta, perché una Circolare del Ministero della Salute indicava anche la tipologia di test rapido da utilizzare per avere un’efficacia paragonabile a quella dei test molecolari.
Purtroppo non abbiamo alcuna certezza che questo accada, perché molti laboratori si limitano a trasmettere il risultato del test, senza indicarne la tipologia. E i test di vecchia generazione, ancora largamente utilizzati, hanno una specificità e sensibilità che, alle prove di laboratorio, si è spesso dimostrata inferiore al 30%. Tirando una monetina, e giocando a testa o croce, risparmieremmo soldi ed avremmo un risultato migliore.
A ulteriore complicazione, i test rapidi non dovrebbero essere utilizzati sulla popolazione generale a fini di tracciamento, ma riservati a situazioni e categorie particolari (come scuole, ospedali, aziende): dove la distribuzione dei singoli soggetti differisce in modo evidente da quella riscontrabile, per l’appunto, nella popolazione generale.
Tutto qui? No, assolutamente. Ancora oggi, dopo oltre due mesi dall’introduzione dei test rapidi nel conteggio totale, per ben 7 Regioni italiane non compare nel Bollettino quotidiano del Ministero della Salute-Iss un dato differenziato tra positivi individuati con test molecolare e positivi individuati con test rapido: sono Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
La popolazione totale di queste Regioni incide per il 18,5% sul totale nazionale, quindi possiamo considerare comunque rilevante un dato calcolato sulle restanti Regioni: ebbene, alla data del 2 marzo 2021 con i test rapidi risultavano individuati 54.162 casi su un totale di 5.552.070 tamponi eseguiti. La percentuale che si ottiene (0,9%) ci restituisce un rapporto positivi/tamponi rapidi quasi ridicolo se confrontato con quello dei test totali (quindi rapidi inclusi) che nello stesso periodo si è mosso in una fascia compresa tra il 4 e il 7%.
Di fatto l’utilizzo dei test rapidi (probabilmente perché in gran parte ancora di vecchia generazione) individua un numero basso di positivi: la conseguenza è che l’individuazione del virus sul territorio è quasi del tutto a carico dei test molecolari, che restano molto lontani dai valori raggiunti a novembre (attualmente il loro numero oscilla tra i 150.000 e i 180.000). La cosa più preoccupante è tuttavia la costante crescita del numero dei test rapidi, che ormai rappresentano il 50% circa dei test totali eseguiti in Italia.
È giusto inoltre ricordare che i test rapidi non sono utilizzabili per il successivo sequenziamento del materiale virale, operazione che invece riveste un’importanza fondamentale per controllare l’evoluzione del Sars-Cov-2 e la diversa distribuzione delle varianti sul territorio.
Ci sono altri 2 aspetti critici, che non possiamo dimenticare: il primo riguarda il numero dei nuovi casi testati. Ovvero, quanti test vengono eseguiti per verificare la circolazione del virus sul territorio, e quanti invece sono riservati ad attività di screening su popolazioni mirate (per esempio gli operatori sanitari) oppure alla verifica di avvenuta guarigione?Anche in questo caso, da novembre e dopo l’introduzione delle fasce colorate, le cose sono peggiorate in modo netto: da una distribuzione del 50-50 tra le due tipologie si è progressivamente scesi a un più modesto 30-70. Ovvero 7 tamponi su 10 sono oggi destinati a valutare gruppi chiusi di persone, su cui vengono eseguiti test periodici, oppure a verificare il decorso della malattia in soggetti già noti.
3) Le misure sono spesso insufficienti e alcune attività comportano un rischio non eliminabile
Il primo punto è facilmente spiegabile, soprattutto alla luce di quanto abbiamo verificato in precedenza sulla tempistica degli interventi: azioni tardive, decise sulla base di un andamento epidemico ormai mutato (e soprattutto se mutato in peggio) regalano al virus uno spazio di almeno una settimana per potersi diffondere in modo significativo. A questo aggiungiamo, ed è di tutta evidenza anche nell’esperienza generale che abbiamo derivato in questi mesi, che le zone gialle sono del tutto inadeguate a mitigare una fase espansiva del contagio, per quanto possa essere modesta. Il risultato finale è sempre un aumento dei numeri: e lo stiamo verificando per l’ennesima volta in queste settimane, dopo che l’Italia dipinta di giallo si sta rapidamente colorando di toni più accesi. Generando così la classica altalena tra restrizioni e allentamenti: con questi ultimi che, pronti a scattare non appena i valori sembrano consentirlo, di fatto annullano in breve tempo i benefici ottenuti con misure di mitigazione più efficaci.
Il perché questo accada è, ancora una volta, scritto nei numeri. A dimostrarlo ci sono ormai decine di ricerche condotte a livello internazionale, in genere considerando particolari settori o attività, oppure popolazioni particolari. Lo studio più completo, che resta ancora oggi il punto di riferimento, è quello condotto dell’Usher Institute (University of Edinburgh) che ha analizzato gli effetti di allentamenti e restrizioni in 131 Paesi. Le cose si sono in realtà ulteriormente complicate, con l’arrivo di variabili più diffusive, ma è utilissimo per capire le dinamiche in gioco.
Cerchiamo di sintetizzarlo per punti:
1) In particolare 5 restrizioni (chiusura delle scuole, limitazioni agli spostamenti, chiusura delle attività produttive, divieto di svolgimento di eventi pubblici e richiesta di restare in casa) manifestano effetti positivi entro 14 giorni. Ognuna di queste è in grado di modificare il valore dell’indice Rt , a 4 settimane dall’introduzione, abbattendolo tra il 3% e il 24%.
2) La riduzione più consistente si ottiene bloccando gli assembramenti (vietarli non basta, se poi avvengono comunque e non si interviene per impedirli).
3) L’incremento del valore di Rt è invece direttamente correlato alla riapertura delle scuole, alla ripresa degli eventi pubblici e della mobilità tra aree geografiche; alla possibilità di riunirsi in gruppi di oltre 10 persone; alla fine della richiesta alla popolazione di rimanere il più possibile a casa. In ognuno di questi casi il valore dell’Rt, dopo 4 settimane, segna un aumento che varia dall’11% al 25%.
4) La riapertura delle scuole, in particolare, nello studio risulta associata a un picco di aumento dopo 7 e 14 giorni.
5) La possibilità di riunirsi in gruppi oltre le 10 persone ha invece una ricaduta più differita nel tempo, con effetti che si manifestano con la massima intensità al termine del periodo considerato di 4 settimane.
A proposito di verità scomode, e al di là dello studio appena citato, è anche giusto ricordare che ci sono alcune attività che, senza alcuna colpa specifica ma in misura maggiore rispetto ad altre, comportano un rischio più elevato di trasmissione del virus. Il caso più volte dibattuto è quello dei ristoranti e dei bar: dove, semplicemente, occorre prendere atto che la mascherina viene obbligatoriamente abbassata. Perché mangiare e bere senza farlo è impossibile.
Lo scafandro delle procedure studiate dall’Iss funziona, o per meglio dire funzionerebbe, solo se le procedure fossero rispettate in modo categorico. Tutti sappiamo che non è così: spesso per colpa dei comportamenti della clientela molto più che per inadempienza dei gestori, che hanno tutto l’interesse a restare aperti, ma il risultato non cambia. Luoghi chiusi dove si riuniscono più di dieci persone, e ci restano per un periodo di tempo lungo, e dove le mascherine vengono abbassate comportano un rischio implicito.
Cogliamo l’occasione anche per rispondere all’ormai scontata domanda: perché a pranzo va bene e alla sera no? Ognuno di noi può decidere come rispondere pensando al comportamento tenuto nel classico pranzo di lavoro, confrontandolo con quello più disinvolto di una cena tra amici. Il primo molto più vicino alle regole indicate dall’Iss, il secondo inevitabilmente molto fuori dagli schemi. Chiedere ai ristoratori di fare i poliziotti, intervenendo sui comportamenti della clientela, è fuori da ogni realtà (oltre che ingiusto e impossibile).
Esattamente come per le scuole, il tema dei bar e dei ristoranti si scontra con una realtà che non è fatta di rispetto tetragono delle regole, ma di costante deviazione dalle stesse. E magari dall’interazione con altri aspetti (per le scuole tutto quello che accade fuori dalle aule) che se decidiamo di non considerare per prese di posizione a prescindere corrisponde, più o meno, a infilare la testa sotto la sabbia.
Se ci sono attività a rischio maggiore, e sappiamo ormai benissimo quali sono, gli sforzi anche economici devono essere concentrati in modo particolare sul loro sostegno. Nell’intento di salvare, in modo mirato e non generico, salute pubblica ed attività economica.
4) I vaccini da soli non bastano, lo dimostrano Israele e Uk
Anche questa è una verità scomoda, ma merita di essere raccontata. I vaccini, che abbiamo ottenuto in tempi record, sono l’arma letale che ci permetterà di uscire dall’emergenza. È assolutamente così, e lo dimostrano tutti gli studi che si stanno moltiplicando nel mondo, insieme ai dati che arrivano ogni giorno, su popolazioni o gruppi di popolazioni che sono stati sottoposti al vaccino.
Vale per Israele e Uk, che sono i primi Paesi per copertura vaccinale rispetto agli abitanti, ma iniziamo a vedere gli stessi effetti anche in Italia se guardiamo al numero dei contagi tra il personale sanitario: negli ultimi 30 giorni il numero dei casi (dati Iss periodo mobile chiuso al 2 marzo 2021) è crollato da oltre il 4,2% calcolato da inizio epidemia all’1,2%. Un valore destinato a ridursi ulteriormente quando tutto il personale sarà vaccinato con doppia dose, e quando saranno trascorsi 10 giorni dalla dose di richiamo.
Allo stesso modo sappiamo che i vaccini (tutti quelli utilizzati finora) hanno un’altissima efficacia, dagli studi in corso superiore al 90%, nel ridurre le forme gravi della malattia. Un altro traguardo importante: perché anche senza riuscire a bloccarla, ridurre la Covid-19 a una patologia del tutto trascurabile, più o meno come un comune raffreddore, sarebbe un risultato straordinario.
Ma i tanto citati casi di Israele e Uk devono essere raccontati senza omettere un particolare fondamentale: la campagna vaccinale, a tappeto, è stata attuata nel pieno di un lockdown rigido. I numeri che vediamo oggi, con un fortissimo calo dei casi giornalieri, non dipendono solo dal vaccino ma dalla combinazione delle misure. Credere che sia sufficiente vaccinare una parte della popolazione per tornare a una corretta gestione dell’epidemia è un errore.
Lasciar correre il contagio, a campagna vaccinale in corso, significa solo limitarne gli effetti positivi: sprecando dosi per vaccinare chi è già protetto in modo naturale, per esempio; ma anche aumentando il rischio che l’infezione asintomatica sia già in corso, o che venga contratta tra la prima e la seconda dose con una maggiore possibilità di vedere insorgere varianti almeno in parte capaci di evitare la risposta anticorpale.
Dobbiamo inoltre considerare che molti degli effetti positivi che si vedono in Israele e in Uk sono legati a una drastica caduta delle forme gravi della patologia, che colpiscono le fasce più vecchie della popolazione. Vaccinando per primi gli anziani si ottiene questo importantissimo effetto, ma nel frattempo i soggetti più giovani continuano a essere soggetti al rischio di infezione.
Non stiamo invocando un nuovo lockdown, sia chiaro: ma se davvero riuscissimo a portare la nostra capacità vaccinale ai livelli sperati (almeno il triplo di quanto facciamo ora) l’altalena giallo-arancio-giallo dovrebbe essere assolutamente evitata, lasciandola in un ambito più legato al marketing cromatico che non all’epidemiologia. Misure tempestive, con chiusure immediate su base locale (anche inter-regionale o inter-provinciale) e attuate sugli ultimi dati disponibili sarebbero il più grande aiuto che possiamo dare al vaccino.
5) Varianti, dispositivi di protezione e comunicazione del rischio
Magari non farà piacere saperlo, ma il Sars-CoV-2 ha iniziato a produrre varianti dal primo giorno in cui ci ha raggiunti contagiando la specie umana. Non può fare altro, perché non è capace di replicarsi senza commettere errori: e sono proprio questi errori (un po’ come se noi sbagliassimo a trascrivere un testo scritto) che generano mutazioni nel suo materiale genetico. Molte sono trascurabili, o del tutto ininfluenti: altre ne cambiano le caratteristiche in modo per lui più favorevole, consentendogli di infettarci più facilmente. È esattamente questo che accade con le varianti inglese, brasiliana, sudafricana e nigeriana: ed è esattamente questo che potrebbe accadere con altre varianti destinate inevitabilmente a selezionarsi fino a quando il virus sarà in circolazione.
Per questo dobbiamo limitare il più possibile il numero delle infezioni: salva vite nell’immediato, ma soprattutto in prospettiva. Riduce il rischio di diminuire l’efficacia dei vaccini e di veder comparire forme virali ancora più rapide ed efficienti nel trasmettersi all’uomo.
L’obiettivo può essere centrato essenzialmente in 3 modi:
1) Con misure di mitigazione in grado di abbattere in modo significativo la curva epidemica, fino a riportarla al di sotto della soglia massima di tracciamento.
2) Con i vaccini, che abbiamo visto devono essere aiutati almeno nelle fasi iniziali con restrizioni che limitino la circolazione virale.
3) Con un utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale.
Su quest’ultimo punto, in particolare, è bene essere molto sinceri: il virus passa dove viene lasciato passare. Una mascherina di tipo FfP2, se correttamente indossata e abbinata a forme di igiene personale come il frequente lavaggio delle mani, costituisce un problema difficilmente superabile per il Sars-CoV-2, anche nella variante inglese. Ed è utilissimo indossarla ogni volta ci si trovi a stretto contatto con altre persone: mezzi pubblici, negozi, centri commerciali. Lasciamo la mascherina chirurgica a situazioni più tranquille, come una passeggiata in una strada con poche persone. Tenendo sempre a mente che, in presenza di un’alta circolazione virale come quella che stiamo fronteggiando oggi, è meglio un eccesso di prudenza che di confidenza.
Il virus non ha imparato a spostare le mascherine, non ci insegue per strada, non penetra nel nostro organismo se non attraverso la respirazione o il contatto diretto del nostro naso e bocca con una quantità sufficiente di materiale virale: per questo è importante, anzi fondamentale, il lavaggio frequente delle mani.
Le protezioni creative a cui assistiamo ancora oggi, incredibilmente dopo un anno di emergenza, sono porte spalancate dalle quali il virus passa con metodica precisione. Indossare una mascherina senza coprire il naso (in quanti lo fanno…), oppure tenendola abbassata sotto al mento (in quanti lo fanno…) è un aiuto straordinario alla diffusione della Covid-19. Così come abbassare la mascherina per parlare, perché così ci sentono meglio: in quel momento stiamo azzerando qualsiasi effetto del dispositivo di protezione, proprio mentre sarebbe più necessario indossarlo.
Il virus viaggia con i nostri errori e grazie ai nostri errori, non ha altro modo: possiamo bere un caffè con gli amici, ma quando abbassiamo la mascherina dobbiamo stare a distanza di “almeno” un metro. Lo stesso metro che dovremmo, in teoria, tenere con altre persone all’interno di un ristorante.
Tra le molte verità scomode non possiamo però dimenticarne una importantissima: non tutto può, né deve, essere ricondotto alla responsabilità personale. Il singolo individuo modifica i propri comportamenti in base alla comunicazione che riceve a proposito del rischio. Se la comunicazione è incompleta, discontinua, discordante o più semplicemente incomprensibile il singolo individuo, in modo inevitabile, cade in errore.
Il continuo racconto del “siamo stati più bravi”, per esempio, genera una sensazione generale che non corrisponde al vero. Non siamo stati più bravi, abbiamo numeri che ci allineano ad altri Paesi tra i più colpiti dalla pandemia a livello europeo e mondiale. Se il nostro essere stati più bravi si misura su quasi 100.000 morti diventa una teoria difficilmente sostenibile.
Se le restrizioni vengono accolte a livello ufficiale come una punizione, e gli allentamenti come un giusto premio, è inevitabile che il comportamento delle persone segua una linea di minore cautela.
Se le regole da seguire mentre stiamo in pubblico sono infarcite di “se” e di “ma” diventano liberamente interpretabili, in base alla sensibilità personale: e quindi perdono gran parte della loro efficacia.
Se mentre stiamo fronteggiando l’inizio della terza ondata (che in realtà è la prosecuzione della prima, mai definitivamente interrotta) veniamo continuamente bersagliati da messaggi che parlano di riaperture e ripresa di una vita normale, non possiamo poi incolpare il singolo individuo se adotta comportamenti più rilassati.
In conclusione, e al di fuori dai 5 punti chiave che abbiamo esaminato, l’ultima verità scomoda che possiamo raccontare è che non siamo fuori dall’emergenza: le prossime settimane saranno difficilissime a livello nazionale, ma soprattutto in alcune Regioni dove il virus ha potuto crescere quasi indisturbato a causa delle restrizioni tardive.
Dobbiamo assolutamente arginare la situazione, compiere quello che tutti speriamo possa essere davvero l’ultimo sforzo per accompagnare la campagna vaccinale verso un pieno successo, e non verso un triste pareggio con il virus.
Finalmente abbiamo i vaccini; sappiamo che in caso di necessità potranno essere aggiornati in modo tempestivo; sappiamo che potremo tenere a bada il Sars-CoV-2 con somministrazioni ripetute nel corso del tempo, forse anche tutti gli anni. Sappiamo che stiamo combattendo una battaglia che siamo perfettamente in grado di vincere.
Ma per ora, al di là di rassicurazioni del tutto fuorvianti, la battaglia è ancora in corso. Il contagio ha ripreso forza e i numeri cresceranno per l’inevitabile inerzia generata dai contagi passati: i numeri che vediamo ogni giorno non ci dicono quante persone sono state infettate oggi, ma quante sono state infettate una settimana prima. È una verità scomoda, ma è giusto esserne consapevoli e prenderne coscienza.
Fonte: 24+ de IlSole24Ore